Imparare a guardare “oltre”
«Noi italiani ricominciamo la grama vita dei secoli passati, parteggiando per paesi stranieri anziché pensare unicamente al nostro paese». Lo scrisse lo statista piemontese Giovanni Giolitti al suo amico Antonio Cefaly, calabrese, vicepresidente del Senato. Era il 5 aprile 1915. Mancavano venti giorni alla firma dell’accordo segreto di Londra che precipitò l’Italia nella fornace della Grande Guerra. Aveva appena compiuto mezzo secolo. All’unità era arrivata con la diplomazia e con la spada: esercito regio e volontari. E anche con “operazioni militari speciali”. Nel settembre 1860 Vittorio Emanuele II invase lo Stato pontificio con un pretesto. Poco dopo irruppe nel regno delle Due Sicilie senza dichiarazione di guerra. Altrettanto fece il 20 settembre 1870 per impedire che nella Roma di Pio IX scoppiasse un’immaginaria rivoluzione repubblicana o garibaldina.
È la storia. Un impasto di atti (irreversibili per quanti ci lasciano la vita) e di piaghe malamente cucite da stipule tra i contendenti. Il conflitto tra il regno d’Italia e la Santa Sede richiese quasi sessant’anni. Si compose con i Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929, inseriti nella Costituzione della Repubblica col voto favorevole del Partito comunista di Togliatti e il no di socialisti, repubblicani, azionisti e liberali. I Patti sono eterni? Anche quelli fra Stato e Chiesa furono revisionati e sono in attesa di aggiornamento. Nulla nella storia è immutabile. I trattati non sono “chiffons de papier” come pare abbia detto la Germania nell’agosto 1914 in procinto di invadere il Belgio, che si considerava al riparo per il trattato che ne garantiva l’immunità. Però non sono eterni. Nascono e muoiono come tutto ciò che è umano. Vincolano gli Stati o i governi che li hanno sottoscritti? Prendiamo il caso dell’adesione dell’Italia alla Nato, un trattato difensivo concepito in una situazione storica circostanziata: la contrapposizione in blocchi, il potenziale conflitto armato tra alcuni Stati “occidentali” e l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel 1948-1949, circondata dai Paesi satelliti. Il governo italiano (ricorda Nico Perrone in Il realismo politico di De Gasperi, BastogiLibri) decise di farne parte l’11 marzo 1949 senza neppure conoscerne lo statuto. Il presidente del Consiglio, il democristiano Alcide De Gasperi, lesse un testo approssimativo. I cittadini non ne sapevano nulla. Il governo, però, aveva le spalle al sicuro perché nelle elezioni del 18 aprile 1948 la Democrazia cristiana aveva vinto molto oltre le sue più rosee speranze (assorbì i voti dei monarchici, orfani dopo la “sconfitta” nel referendum del 2-3 giugno 1946) mentre il Fronte popolare socialcomunista, incorporata un’ala del partito d’azione, subì una durissima sconfitta.
Un’ampia parte dell’elettorato “moderato” era del tutto contraria a vincolare l’Italia a blocco militare. Alla fine della guerra la Democrazia cristiana era per la neutralità. Molti pensatori cattolici distinguevano anzi fra pacifismo e neutralità, in linea con Pio X, che (ricorda il suo biografo Gianpaolo Romanato) morì con l’incubo del “Guerrone” incombente, e con Benedetto XV, ancora sottovalutato dalla storiografia, predicò il pacifismo. Era la missione della Chiesa di Roma in un’epoca che vide i cristiani schierarsi e dilaniarsi in subordine ai governi dei Paesi nei quali vivevano. Accadde per evangelici, riformati e anche per i cattolici. Quelli del Belgio e della Francia si attendevano la condanna pontificia della tracotanza germanica, mentre i bavaresi e gli austro-ungheresi erano ansiosi di ottenere la benedizione del papa per la loro vittoria su gallicani, anglicani e Russia ortodossa. Lo documenta il poderoso volume Santa Sede e cattolici nel mondo posbellico (1918-1922), atti di un convegno promosso dal Pontificio comitato di scienze storiche (Libreria Editrice Vaticana). La guerra divise anche pacifisti, liberi pensatori e massoni, come ha documentato Yves Hivert-Messeca nella poderosa storia dell’Europa sotto l’Acacia (ed. Dervy): un arbusto con poche foglie squassate dai venti di governi che da decenni vivevano per la vendetta.
Non da oggi, dunque, i Trattati sono da un canto e le buone intenzioni dall’altro. Dichiarare (come fa la senatrice Liliana Segre) che dinnanzi al conflitto attuale è impossibile rimanere “equidistanti” e che “non ci si può voltare dall’altra parte” (lo sostiene, fra altri, anche Mario Draghi) e bisogna dunque schierarsi, anche con le armi, è comprensibile nell’ottica dei buoni sentimenti. Ma è retorico sul piano della storia, perché, se davvero così fosse, gli aspiranti “custodi del bene” e della “democrazia” dovrebbero accorrere a raddrizzare i torti quotidianamente perpetrati in tutti i continenti da grandi, medie e talvolta piccole ma bene armate potenze, nonché da pseudostati come l’Isis e da movimenti terroristici vari, contro nemici esterni, veri o supposti, o minoranze interne, in taluni casi realmente presenti, in altri del tutto inventate da chi per rimanere al potere ha bisogno di additare un “nemico”.
Anziché voltarsi verso uno dei fronti in lotta, a cospetto di un conflitto potenzialmente devastante occorre guardare oltre per disinnescare il terreno dalle mine seminate per decenni e così diffuse da rendere difficile il dialogo. Da qualche settimana le operazioni belliche in corso nell’Europa orientale hanno catapultato la generalità dei cittadini dalla pressoché completa indifferenza (o magari anche ignoranza) della “grande politica” (cioè quella estera e militare e la lotta per il controllo delle indispensabili “materie prime”: anzitutto i metalli rari) alla visione quotidiana dei combattimenti: file chilometriche di carri armati, scie dei missili, edifici sventrati, persone chiuse nei rifugi o in fuga, donne, bambini, lacrime. La “guerra”, che dal 1945 non aveva mai cessato di serpeggiare nel pianeta come gramigna inestirpabile, è divenuta un soggetto ordinario. Aveva suscitato qualche apprensione quando divampò nel Vicino e Medio Oriente e persino in Libia, di cui si ricorda il truce supplizio inflitto a Gheddafi ma della cui condizione effettiva odierna si sono perse le tracce. Così come nulla si dice sistematicamente dei feroci conflitti in corso in tanti paesi dell’Africa subsahariana, che fanno notizia solo quando vi cade un cittadino italiano, come avvenne in Congo. Lo stesso vale per vaste aree dell’Asia, già teatro di guerre mai dichiarate e nondimeno atroci, come Vietnam, Cambogia, Laos. Se non fosse per la titolare di un discusso premio Nobel per la pace (venne conferito ante litteram anche a Barak Obama, non proprio una crocerossina), la Birmania sarebbe a sua volta nel cono d’ombra che avvolge lo Yemen, uno tra i più generosi spacci di morte con armi importate da paesi che proclamano di “rifiutare la guerra” ma la fanno fare agli altri.
L’abbondanza di “immagini” sul conflitto soffoca la ricerca delle “spiegazioni”. La “storia”, si sa, è noiosa, perché comporta di colmare il vuoto di informazioni che ha caratterizzato i media (anche in Italia) da quando, ormai da anni, fu chiaro che la Nato si sarebbe ritirata dall’Afghanistan, fallimento strategico di una costosissima “operazione” troppo a lungo narrata come doverosa “esportazione della democrazia”: quasi che principi e costumi che hanno richiesto secoli per affermarsi possano essere “trapiantati”. È la litania anche oggi ripetuta: con l’attenuante che non si parla più di prodotto da esportazione ma di tutela del marchio e del suo uso anche da parte di Paesi, come l’Ucraina, che non ne sono affatto specchio e la cui storia è (o dovrebbe essere) nota a quanti oggi si avvolgono nei suoi colori senza conoscerla.
Sommersi da ripetitivi e infine stucchevoli primi piani dell’orrore (poco o nulla al confronto di quelli che si vedono in film e fiction anche in prima serata), anziché auspicare una rapida composizione diplomatica del confronto militare in corso forse troppi sono ansiosi di vedere il secondo e il terzo tempo (dopo il lancio degli ipersonici Kinzhal, chi sgancerà per primo testate nucleari?), come se i contendenti fossero squadre di calcio o una lotta tra galli o cani da combattimento.
Si è così imboccata una china pericolosa perché la “visione” genera assuefazione e condivisione non delle motivazioni dell’uno o dell’altro contendente ma della guerra in sé: uno “spettacolo” che alterna mestizia e tracotanza, vittime inconsapevoli e armigeri burbanzosi come l’Europa (e non essa sola) ha veduto nel corso dei secoli, in specie nella rovinosa Guerra dei Trent’anni di cui fu matrice nel 1914-1945 e dalla quale uscì prostrata ma non abbastanza morigerata.
Perciò è opportuno riflettere su alcuni concetti ritornati in auge con la tragedia in corso. Tra i suoi ingredienti domina l’endiade confini-autodeterminazione dei popoli.
Autodeterminazione
L’autodeterminazione fu tra gli ingredienti delle lotte per l’indipendenza nazionale in risposta all’espansione della Repubblica francese del 1792 e del suo maggiore beneficiario, Napoleone I, che ne trasse i fondamenti ideologici per affermare l’Impero. Per l’eterogenesi dei fini, l’espansionismo napoleonico, sorretto dai marescialli dell’impero (precursori degli oligarchi odierni: non solo russi…) e il blocco continentale suscitarono la rivolta antifrancese in Spagna, mai tanto unita come nella guerra per l’indipendenza da Parigi, in Germania e in Italia, a cominciare dalla solitamente quieta Milano. L’autodeterminazione ebbe poi enunciazione solenne l’8 gennaio 1918 nei Quattordici punti del presidente degli USA, Wilson, al Congresso americano quale base per la futura pace mondiale. A parte asserzioni che ne mettono a nudo la completa disinformazione (è il caso dell’accoglienza della Russia nella Lega delle Nazioni “sotto un governo che essa stessa avrà scelto”: Lenin era già al potere), Wilson affermò che “i popoli e le province non devono costituire oggetto di mercato e passare di sovranità in sovranità, come fossero semplici oggetti o semplici pedine di giuoco, sia pure del grande gioco, ora screditato per sempre, dell’equilibrio delle forze”. Le aspirazioni nazionali andavano soddisfatte senza suscitare nuovi elementi di discordia suscettibili col tempo di rompere la pace dell’Europa e di conseguenza del mondo.
I confini
Ma l’autodeterminazione in Europa avrebbe portato alla deflagrazione di ogni forma di Stato, sia recente sia antico. Gli Stati si formarono con l’imposizione del centralismo sulla variegata molteplicità delle realtà etniche, linguistiche, religiose e costumali preesistenti. Nacquero dai conflitti interstatuali che favorirono la sovrapposizione delle monarchie sui popoli riottosi al loro interno. Ma le differenze rimasero, pronte sempre a riaffiorare con i pretesti più vari. I casi dell’Irlanda del Nord, dei Paesi Baschi, della Corsica e della Catalogna sono solo i più clamorosi. L’Italia ha temperato le spinte antiunitarie concedendo statuti “speciali”, ormai anacronistici, o larghe autonomie regionali che hanno favorito i potentati locali e paralizzato le istituzioni centrali.
La contraddizione drammatica tra autodeterminazione e certezza dei confini è insita nella labilità dell’identità nazionale nelle terre mistilingue, croce (molto sofferta) e delizia (poca) dell’Europa del Novecento, che registrò continui spostamenti di confini e conseguenti micro pulizie etniche, spesso feroci ma tenuti ai margini dell’attenzione perché “così facevan tutti”. Il caso del confine italo-jugoslavo, italo-austriaco e della valle d’Aosta (ma altro si potrebbe aggiungere sulla scorta del robusto volume di Luigi Iperti Storie di frontiera. Il secondo dopoguerra ai confini occidentali (ed. De Ferrari). Il garbuglio era chiaro a Wilson il cui punto 9 recitò: “Una rettifica delle frontiere italiane dovrà essere effettuata secondo le linee di nazionalità chiaramente riconoscibili”. Un’operazione impossibile senza ricorso alla separazione forzata degli italofoni da germanofoni e slavofoni. Non per caso nelle “terre liberate” l’annessione avvenne sulla base dei trattati di pace, senza plebisciti confermativi. Lo stesso e peggio accadde ripetutamente nell’Europa orientale, in specie ai danni della Germania e con l’invenzione di Stati multietnici che non hanno retto al tempo (come la Cecoslovacchia). Alla luce di questi dati sommari risulta curiosa la proposta di risolvere il caso odierno con una soluzione “alla Cipro”: ovvero l’irrigidimento perpetuo delle diversità, fomite di conflitti permanenti.
La centralità del Parlamento
La bilancia dei poteri istituzionali in Italia dalla proclamazione del regno alla Costituzione del 1948 apparve quale un triangolo scaleno: tre lati di diversa lunghezza. Il maggiore era costituito dal re, capo dello Stato e comandante delle forze armate, dominus della politica estera. Poi veniva il lato minore: il governo, formato da ministri nominati e revocati dal sovrano (art. 65 dello Statuto). Infine il lato ancora più corto, la base del triangolo, costituita dal parlamento, composto di due camere: il senato, di nomina regia, e la camera dei deputati, elettiva. L’ampliamento dell’elettorato parve allungare la base del triangolo e, di conseguenza, la rappresentatività dell’esecutivo, che doveva contare sulla fiducia del parlamento. Se i poteri fossero stati meglio bilanciati, il triangolo sarebbe divenuto isoscele, tendente a trasformarsi in equilatero. Invece il loro rapporto formale e sostanziale continuò a essere squilibrato a vantaggio della Corona e del governo, espressione diretta del sovrano. La Camera dei deputati poté invero ostacolare l’esecutivo e costringerlo alle dimissioni. Lo fece più volte dall’inizio del regno di Vittorio Emanuele III e anche nel corso della Grande Guerra, nel giugno 1916 e nell’ottobre 1917. Però, a Statuto immutato, fu sempre il re a incaricare via via il presidente del consiglio, a nominare ministri e sottosegretari e a decidere il corso della vita politica. Il triangolo rimase dunque scaleno, qual era nel regno di Sardegna dal 1848 e in quello d’Italia dal 1861.
Ma dal 1948 la sovranità risiede nel Parlamento. Lì debbono essere discusse le decisioni supreme di un Paese che sin dalla resa senza condizioni del settembre 1943 e dal Trattato di pace del 1947 ha subìto pesanti limitazioni della propria sovranità e altrettante si è autoimposto.
Pacta servanda? Sì. Il patto tra i cittadini e le istituzioni, e viceversa.
A cospetto della crisi in corso emerge una considerazione finale. Se invece di Camere che si trascinano sino all’estenuazione gli italiani avessero oggi un Parlamento fresco di elezione, sulla base della riforma che il medesimo ha (sconsideratamente) approvato, essi disporrebbero di una maggioranza certamente più rappresentativa di quella che a fine gennaio del 2022, in uno snodo politico-istituzionale cruciale, ha rieletto capo dello Stato il presidente uscente, implicitamente confermando presidente del governo quello in carica. Tutto è accaduto mentre “l’operazione militare speciale” bolliva già in pentola e in Italia vigoreggiava una campagna elettorale strisciante, ma sempre più accanita, tra partiti che, nel migliore dei casi, contano più o meno il 20% dei consensi del 60% di chi ancora va alle urne. Cioè poco più di niente. Pertanto, se il conflitto in corso nell’Europa orientale dovesse perdurare, esso si ripercuoterebbe pesantemente all’interno del Paese, mettendone in luce le debolezze intrinseche.
Nel 1939 l’Italia si guardò dall’entrare in guerra a fianco della Germania e presentò a Berlino la lista di quanto le sarebbe occorso per scendere in campo, compreso il molibdeno, indispensabile come il vanadio e il volframio. Piccole cose rispetto ai bisogni odierni…
Ecco perché urge guardare “oltre”.
Aldo A. Mola
Ferdinando MARTINI (immagini tratte da http://www.letteraturadimenticata.it/Martini.htm)
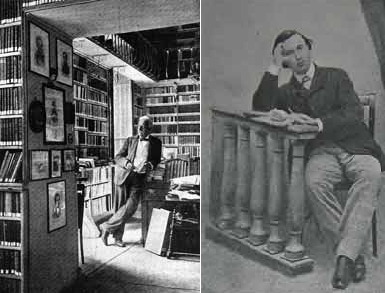
Il 28 luglio 1914 Ferdinando Martini (1841-1928), deputato dal 1876, già ministro dell’Istruzione nel primo governo Giolitti (1892-1893), governatore dell’Eritrea (1897-1907) e ministro delle Colonie nel primo governo Salandra, decise di tenere un “Diario” per ricordare «ciò che ho detto ed ho fatto, ciò che fu detto o fu fatto da altri e da me insieme». «Siamo sotto la minaccia di avvenimenti gravissimi. L’Europa rischia di divenire un compiacente morto alla mercé dell’America e dei popoli dell’Estremo Oriente. In sostanza il problema è questo e pare, e forse è, insolubile; l’Italia non può fare la guerra e non può non la fare […] Salus patriae suprema lex».
Il 24 aprile Martini annotò: «Il Re ha il difetto d’esser troppo… come debbo dire? moderno. Non crede egli stesso alla Monarchia o almeno all’avvenire delle monarchie; nato borghese, sarebbe stato repubblicano e forse socialista. È intelligente e colto; ma a furia di non credere nella propria forza ha finito col perderla. […] Oggi nessuno si occupa di lui, di sapere, in momenti così gravi, quale sia la sua opinione, a quale meta egli miri, quale via sia per battere: se alcuno pensa a lui è per lagnarsi ch’egli non si faccia valere, che si nasconda anzi…».
Si, considerazioni approfondite di ordine storico, ed umano.
Le ragioni dei conflitti ed il conflitto strutturale tra autodeterminazione dei popoli e composizione dei popoli, mescolati, spesso, ed oggi sempre di più, sulla medesima base geografica, come I Rohinga, provenienti dal musulmano Bangladesh ed approdati in Myanmar, dove avanzarono la pretesa di costituire un’entità autonoma su quel territorio, una volta diventati numerosi.
Distorsioni della Storia, che dipinge il caos delle pulsioni umane, degli interessi e quindi dei conflitti. Ma tutto questo a che pro, parlando di Ucraina?
L’Ucraina non è la Siria, o la Cecenia. Tutti i conflitti sono esecrabili, ma quanto lo siano, per noi, dipende dalla PROSSIMITA’, geografica e di interessi.
La Cecenia è lontana, la Siria anche, la Libia già molto meno.
L’Ucraina è vicina, è alle nostre porte e la visione politica che anima la leadership russa conduce la Russia ai nostri confini immediati, persino italiani, non solo europei, perché la Serbia filorussa è dietro l’angolo.
In questi casi non c’è molto da riflettere, non esiste il pacifismo, non esistono i dubbi e le giustificazioni, che esprimono ben altro che una lucida analisi: ci si schiera, da una parte o dall’altra, senza se e senza ma, e chi non si schiera con un paese aggredito, nei fatti, ma con il suo aggressore, appare a me come un potenziale traditore della sua stessa patria, un cavallo di troia da cui, un giorno, potrebbero uscire guerrieri russi, o a loro vicini.
Tutto il resto è RETORICA ….
Franco Puglia